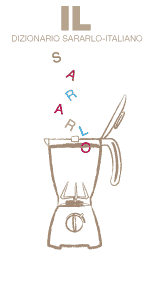AMARCORD (trentanni a tutta Gola)
Una specie di autodafè, lungo i percorsi delle emozioni provate per le tavole (e i personaggi) del nostro Paese. Un Amarcord scritto, comunque, più con il cuore che con il resto. Pubblicato su IDR viene qui orgogliosamente riproposto.
L’Educazione Gastronomica è un po’ come l’educazione sentimentale e, per ognuno di noi, può aver seguito percorsi di coinvolgimento emozionale e palatale diverso, cangiante anche con il nostro maturare per i sentieri della vita, abbinata a pignatta, nello specifico.
Chi scrive veleggia more or less per un ipotetico trentennale di zingarate, più o meno blasonate, attraverso tavole di alto lignaggio, così come di umile tovagliato a gestione familiare. Qualche flash back, quindi, a volte ritorna in mente, come quel piacevole refrain di un Battisti mai dimenticato.
Intimismo Gozzaniano del tempo che fu? Macchè, siamo tuttora armati di curiosità e cupidigia a mangiare il futuro prossimo, vicino e lontano.
Rimpianto di quando si poteva razzolare, impenitenti, da fisico ventenne? Giammai, la mamma ci ha fatto forti, e anche se qualche trapunta di ciccia sparsa occhieggia qua e là, ci dicono che le coronarie viaggiano ancora buone.
No, semplicemente lo spunto è venuto recentemente nel sederci a tavola amica che amiamo e che è quella di Aimo e Nadia, in quel di Via Montecuccoli, nel Gran Milàn.
Per certi versi Aimo Moroni è stato il nostro Alberto Manzi di materia prima quando, sul finire degli anni ’80, vi era una certa confusione tra Territorio e Presalè; con le Frattaglie Cenerentola sloggiate di Carta dal più nobile Foie Gras con passaporto transalpino.
Aimo è stato Testimonial di territori e produttori ben prima che arrivassero i Presidi S.F., e di questo gli saremo sempre riconoscenti.
Tuttavia, quando l’abbiamo conosciuto, Aimo era un signore nel pieno della maturità tardo cinquantenne; l’altro giorno lo guardavamo: l’occhio entusiasta, la descrizione sapiente erano immutate, ma la carrozzeria veleggia di primi anni ’70, pur portati con gagliarda tenacia.
Ergo, anche lo Zio Aimo, tra qualche lustro, ci porterà Gli Spaghetti Selezione Capelli con Cipollotto e Peperoncino in forma di piacevoli ricordi virtuali, più impegnato a fare il Nonno e a godersi con la sua Nadia il famoso Raggio Verde dopo una vita spesa tra mercato, sala e pignatta.
E allora, in questi giorni, ripercorrendo le mille e mille tappe dello stare (anche) a tavola, ci sono ritornati alla mente uno, due episodi, di figure o deschi passati nell’archivio della memoria, perché i protagonisti sono “altrove” o, più semplicemente, perchè sono cambiati alcuni scenari o alcune condizioni.
Poi, mano a mano, ci siamo accorti che a ricordo si aggiungevano ricordi, e la galleria era bella ricca di personaggi, di situazioni che fa piacere riassaporare, e non solo per questioni organolettiche, e neanche con la lacrima di saudade o lo spleen di un Tango a Mendoza ma, nel caso, per darne un saluto al merito e, magari, per arricchire, su alcune figure, ricordi altrui, se non addirittura implementare una galleria di Locali, Patron, Chef che hanno dato contributo significativo alla Storia minore di un’Italia Gastronomica in perenne fermento.
Cominciamo da Milano, quindi, da dove l’idea ha preso idealmente spunto, in un’ ipotetico Giro d’Italia un poco vintage, ma non crepuscolare.
Uno dei grandi vecchi che ha caratterizzato la ristorazione meneghina di fine ‘900 è stato senza dubbio Bernardo Valli.
Al suo San Bernardo (*) si ritrovava la buona borghesia che rifuggiva i cortei di Marco Capanna e condivideva, a tavola, i dettami dell’ edonismo reganiano, sulle orme del gusto e di una tradizione lumbard e pre.bossiana.
L’ ambiente era classico, elegante; il personale di Sala era di quelli che avevano mangiato la foglia da tempo.
Inappuntabili certo, ma erano come quei fattori cui il padrone ha da tempo dato delega nello sbrigare dei lavori quotidiani.
I ricordi sono essenzialmente due: il Risotto alla Gianni Brera e il Fojolo.
Il Fojolo era un certo tipo di trippa alla milanese, quindi tagliato a fettine molto sottili: una julienne di trippa con un belletto di pummarò. L’abbiamo anche cercata dal Masuelli, ma non l’abbiamo più trovata uguale.
Il Risotto alla Gianni Brera ci stava perfettamente con il personaggio ed era bello quanto il racconto che lo accompagnava.
Il Risotto parlava pavese, quindi con rosso d’uovo, fagioli, salsiccia e forse qualcos’altro.
“Schiacciato” alla piastra e servito a mo’ di pizza con parmigiano che, su consiglio della casa, veniva disposto a farne cornice lungo tutto il piatto. “Così amava fare Gianni Brera”, perchè era perennemente a dieta e voleva limitarsi con i grassi. Quindi, a piacere, partiva dall’alto del piatto e portava il formaggio a maritarsi con il risotto, ma, nel caso, poteva anche mangiare il risotto e basta. Suggestivo. Ci ricorda un vecchio adagio di Montanelli: “l’importante non è che una notizia sia vera…ma verosimile”. La mancia alla Sala era conseguente.
Poi il buon Bernardo è passato nel mondo dei più e non sembra che il figlio abbia saputo raccogliere adeguata eredità, anche se pare che il Risotto del Gioàn fu Carlo ci sia ancora…
***
In una scheda dell’ Espresso settimanale avevamo letto e visto di un mirabolante Astice alla Kandinsky, in cui svettava in quadricromia un astice pittato di blu, forse colore preferito del pennello citato e famoso.
L’opera si poteva gustare alla “Scaletta” (*), storico locale dalle parti di Porta Genova, dove per decenni la Signora (*)
(lapsus di memoria) aveva servito generazioni e generazioni di milanesi.
Il Locale di questa ideale Rina Morelli dei fornelli l’avevamo memorizzato e segnato da tempo, ma era sempre in waiting list.
“Kandisky” è stata la molla finale, anche perché sapevamo che la gestione stava per passare di mano.
Ed ecco che si presenta l’occasione.
Emozionati, pronti a gustar l’evento, saliamo con rispetto i tre scalini, ma all’apertura dell’uscio non troviamo saluto muliebre ma i tratti somatici di quello che sembrava il maggiordomo di Casa Corleone.
Ci sediamo. Guardiamo intorno; forse la signora era momentaneamente indisposta.
Con un cenno del mento il Jeeves delle Madonie chiama degno picciotto.
Ci guardiamo intorno di nuovo, memorizziamo bene la via d’uscita.
Chiediamo della Signora…. È cambiata la gestione l’altro ieri.
Chiediamo di Mr. Astice Kandisky … non c’è, figurarsi; al suo posto un Aragosta in Bellavista, così come parlò De Crescenzo, probabilmente.
Prendiamo tempo … siamo in dieta .. magari un primo, così, tanto per gradire.
Abbiamo un “Tris”, se il signore desidera ...
Abbiamo paura che buttino via le chiavi, ok per il Tris.
Arriva, traccheggiamo; ci inventiamo una gastrite fulminante … ce l’aveva detto il medico di mangiare in bianco.
Corleone ci guarda, chiama il taxi … Via Montecuccoli, Please … Amico Aimo, ancora di salvezza e di … palamito.
Dieci portate, alla faccia della fanta gastrite, di Mario Puzo e con lo spleen di non aver conosciuto la Rina Morelli della ristorazione milanese e nemmeno il suo astice pittato.
***
Eravamo ancora apprendisti stregoni, invero, da poco usciti, grazie alla professione, dai confini di tavole circondariali (intese come locali) e universitarie, ma di “Lui” sapevamo già: avevamo letto, riletto e deglutito.
Ma, come in tutte le prime volte, anche con lui siamo giunti al dunque e ci siamo seduti in Via Bonvesin della Riva.
Mi pare che si scendeva di qualche gradino e si arrivava in questa Sala in cui, sin da subito, ci ha accompagnato una delle caratteristiche che poi, ancora adesso, ha mantenuto ad Erbusco. Piccole opere d’ arte distribuite, diverse, ad ogni tavolo. Mi piaceva Gio’ Pomodoro, con la sua architettura unica e riconoscibile e, infatti, lì lo trovai.
Gualtiero Marchesi era in pieno boom mediatico, fresco di copertina su Time.
La compagnia, allora, non era delle migliori, anche perchè facevo da palato cocchiero a colleghi più anziani, cui però, del gastromondo, importava in maniera relativa. Erano i tempi in cui si poteva ancora fumare a tavola, e pure in tavola stellata. Gli argomenti, poi, erano più da Pigalle che da Bocuse & dintorni.
Comunque, ricordo ancora l’ emozione nel vedermi finalmente al piatto il famoso Risotto con la foglia d’oro, oppure le Seppie (*) e il resto sfuma, oggettivamente, nel ricordo di anagrafe dettagliata.
Ritornato poi in altre occasioni, ho spazzolato puntualmente tutto il repertorio con stupore e divertimento per le invenzioni del Divin Gualtiero, anche se, tuttavia, forse perché era mezzogiorno, qualsiasi incontro con il genius loci era rinviato per la di lui assenza e il servizio non era sempre all’altezza della cucina; anzi, qualche volta, nell’attardarsi su orari che per altri erano di siesta pomeridiana, vuoi il Sommelier, vuoi il Maitre ci confessavano che sì, bella esperienza, ineguagliabile il Maestro, ma che la prossima settimana avevano già un contratto pronto per volare e lavorare a Londra, New York, Parigi.
***
In zona Porta Genova (*) ha debuttato una delle pignatte blasonate della Milano attuale, quel Claudio Sadler che, all’inizio, era in quella che, forse, si chiamava Osteria dei Binari (*).
C’era curiosità nel sedersi alla sua tavola. Il giovane era cordiale, aveva dei numeri; è stato uno dei pochi che mi ha sconfitto mettendomi alle corde che, nel linguaggio sararliano, vuol dire non aver terminato completamente la comanda lasciando qualche mozzicone di astice o mignon pasticciera sul piatto… .
Era interessante, meglio, prometteva crescita e maturazione di talento; poi, quando si è trasferito nel nuovo locale, siamo tornati a trovarlo, ma l’esperienza è stata deludente, non solo per cotture e abbinamenti, ma anche per inversioni di comanda che hanno stravolto la sequenza di paccheri e piccioni.
Si vedeva ancora la pelata tra i fornelli, ma si capiva che la testa, quella pensante, era altrove, tra catering e leasing di gastrofinanza.
***
Nelle nebbiosità che da Piazza Duomo scendevano verso l’ Oltrepò, si poteva sempre trovare un sole che, se non abbronzava i glutei, scaldava i cuori e la panza: “Il Sole”, a Maleo, di tale Franco Colombani.
Ci siamo capitati una sola volta, al pranzo della domenica.
La cascina era di quelle ristrutturate, con buon equilibrio tra lusso, buongusto e country style.
La compagnia era assortita e, curiosamente, si trovava riunita attorno a tavolata comune, cosa in uso, nel Veneto centrale, un tempo, nei locali per blue collar dove, a pranzo, si ragionava di malta, talami corsari e abatini vari.
Alla Tavola dei Colombani, invece, c’era un rassemblement composito, dalla famiglia padrona del vapore, agli artisti illuminati e qualche bohemien.
Si ragionava del più e del meno, la maggior parte generalmente griffati Missoni, come il tovagliame della casa.
Un’ esperienza piacevole, anche sul piano umano, di cui abbiamo riportato ricordo con un libro di ricette di un Colombani che, sul finire, non faceva mistero di concetti ed espressioni di un animo in fase di reflusso.
Qualche mese dopo decise di por fine ai suoi giorni; voci di corridoio narravano di una consorte tanto bella, quanto incapace di abbronzarsi ai raggi di Maleo, ma in cerca di calore altrove …
***
Nella nostra professione, uno dei fari del sapere si trovava dalle parti di Saluzzo, a qualche lega o poco più dal Bengodi di Trifola, quel paradiso langarolo in cui il tardo autunno era stagione eletta.
Ovviamente sceglievamo i Corsi che meglio conciliavano trapano & trifola in un ideale TT manco fosse un Audi o (visti i tempi) una NSU.
Per andare da Guido, a Costigliole, bisognava attrezzarsi di reservation settimane per tempo, anche perché erano aperti solo la sera.
Il locale era in una delle piazze del paese.
Da fuori sembrava un negozio chiuso per ferie.
C’erano le transenne metalliche e, dal vetro, si vedeva un tappeto e si indovinava che bisognava scendere una rampa di scale.
La bellezza era in quella discesa da Wanda Osiris di papilla perché, invece che dagli applausi del pubblico, venivate investiti in pieno petto e nari, da un tornado di Tuber Magnatum Pico che vi restava avvinghiato alle vesti anche il giorno appresso, manco vi foste annottati instancabili con Marylin e il suo Chanel.
Se Pavlov ha un senso, ancora adesso, a distanza di quindicianni, il riflesso gustativo stimola effetti collaterali simili ad allora (parliamo di trifola e inondazioni salivari, e non da effetti marylin indotti …)
La Tavola era conseguente. Lidia Alciati era in cucina; il buon Guido, con il suo fare cortese pur apparentemente appesantito da stazza langarola, era gentile ai tavoli, ma lasciava fare ai figli che dovevano raccoglierne l’eredità.
I ricordi? Di Tajarin, di Agnolotti del plin, di un carrello dei Formaggi strepitoso. Sentori di gentilezza e passione ognidove.
Il tocco di classe. A fine serata, in un angolo a sottoscala, c’era un teutonico adottato in loco che, con straordinaria capacità amanuense, ci scriveva in bella calligrafia il Menù che avevamo appena celebrato.
Il tutto racchiuso in una cartellina rosso antico in cui, nel lato a fianco della comanda scripta, c’era una piccola serigrafia d’autore, lo scribano appunto, numerata e a tiratura limitata, only for you.
Quando il piacere dello stare a tavola non deve solo soddisfare villi digestivi, ma va anche lì ove si producono endorfine e benefici associati.
***
In questo pendolare a Nord Ovest, la discesa nel Golfo dei Poeti era inevitabile, anche perché ivi era un altro dei fari a cui rivolgere l’attenzione di una formazione professionale volontaria (per latitanza universitaria).
Welcome in La Spezia.
C’è il ricordo della scoperta dei Testaroli o della Mesciua, una minestra di cereali, quest’ultima, che si trovava solo, allora, ai primi tornanti che portavano verso Ponente. Il nome del locale è dimenticato, ma non il volto dell’anziana signora che ci serviva il piatto condendolo di amore e passione, come fossimo di lei nipote. Poiché non è possibile verificare il nome del locale, e non sapendo se la signora è ancora lì, tra i suoi fornelli e i suoi cereali, è solo un tributo di affetto e riconoscenza.
Mentre invece, a Levante, per anni abbiamo avuto il nostro riferimento in quel di Sarzana,
alla “Scaletta” (l’ altra, considerati i precedenti). Il locale era molto semplice.
Una casa/trattoria dalle ampie vetrate in cui, come a Milano, si saliva qualche gradino per godere in santa pace il riposo del giusto. L’importante, su quegli scalini, era la discesa, specialmente se Bacco era stato giocoso e generoso compare.
Il Signore era un po’ anziano, ma non tanto.
Affettava con maestria i salumi da servire come entrè, con il pane a legna, ovviamente, e i sottoli della casa, così come
il vino, che era onesto e sincero e non sapeva nè di muffe né di barrique.
I piatti erano semplici, come si usava in un ambito di clientela familiare e di desinare quotidiano, ma era tutto buono e evidentemente a portata sia del taccuino semplice come di quello appassionato, e si parla di polli e conigli, ottimi, di cortile vero.
Poi ha passato la mano, chissà, non abbiano neanche più voluto verificare se Don Corleone era arrivato pure lì.
***
E sulle bocche del Magra pancia mia fatti capanna.
Angelo Paracucchi era un assisano che, forse unto dal suo conterraneo Beato, aprì quella Locanda dell’ Angelo che i figli mandano avanti ancora adesso. Tuttavia si può dire che, sul finire dei roaring ’70, era l’unico che, assieme a Marchesi, stava facendo girare il buon nome della Cucina Italiana anche oltre confine; tanto è vero che fu il primo a sfidare gli indiscussi cugini d’oltralpe sul loro stesso terreno, nella Ville Lumière.
E’ passato molto tempo e due anni fa, ritiratosi oramai dai fornelli, è andato a passeggiare per i pascoli del cielo, ma rimane ancora adesso impressa la sua figura di omone tranquillo dallo sguardo dolce e, nella nostra memoria visiva, è vivo ancora l’impatto di uno dei suoi piatti d’eccellenza: una fantastica Tempura preparata direttamente al tavolo ….
***
Costeggiando l’Apennino e ritornando verso Est non poteva mancare una sosta al San Domenico, in quel di Imola.
Il locale c’è ancora adesso, invero, ma non più con alla guida Gianluigi Morini, questo ex bancario che, antesignano sui tempi, lasciò la professione per dedicarsi alla sua passione, quella vera, di un’ospitalità tradotta per Cantina e Cucina.
In Cucina portò uno dei campioni di allora: Nino Bergese; in Cantina parte della sua collezione privata, comodamente coibentata nelle segrete di un ex convento di alcuni secoli addietro.
Gli interni del locale ricordavano uno stile un po’ liberty; il sorriso di Morini metteva a suo agio chi era evidentemente ai suoi debutti di palato, anche se qualcuno era veramente un parvenu.
Come detto, allora, giravo (malgrè moi) con compagnia all’altezza più di danè che di papilla.
Da sprofondare, una volta. Indegno compare di tavola, marlboro all’angolo come un Bogart de’ borgata, all’ arrivo di delicati Tagliolini con i Gamberi rossi di Sanremo chiede …il grana.
Il govane commis rimane perplesso, perché gli avevano insegnato che accussì non si usa.
Si gira, guarda Morini; Morini in piano sequenza da Antonioni di lunga militanza, aveva già filmato tutta la scena; si avvicina, sorridente, e versa con generosità la farina di vacca al nostro che, sbuffandogli Marlboro Country Style in faccia, lo ringrazia ad alta voce.
Non siamo più usciti con questo Barone del trapano, ma Morini siamo andati a trovarlo altre volte, imperturbabilmente gentile e cordiale con tutti.
Da non perdere la visita alla Cantina, e non solo per i tesori bordolesi e champagnotti, ma anche montalcini, che forse hanno trovato contraltare inizialmente solo in via Ghibellina; incredibile “Il” Palco di tramezzo, una sorta di enclave paradisiaca separata dalla Sala e con vista panoramica sulla Cantina in cui, un privilegiato gruppo di dodici Cavalieri di Palato, poteva gustare le delizie della Cucina, beandosi di una vista (e una possibilità di scelta) senza pari.
Divertente anche qualche siparietto dove questo Signore d’antan, a fine serata, era raggiunto dalla paziente consorte che, presa confidenza con l’avventore, confessava anche, ahimè, i suoi desideri infranti per qualche pelliccia regolarmente bypassata da investimenti altrove, leggi Chateaux, sempre di razza, che diamine, ma che non erano di lince o visone.
Poi, forse, Morini si è fatto prendere la mano e, come Paracucchi ha aperto una ambasciata a Parigi, il nostro è volato oltre Atlantico, dove ha trovato in Tony Maj jont venture yankee.
Leggenda narra che, addirittura, le Tagliatelle venivano tirate con l’acqua del Santerno, per poi venire spedite quotidie by Jumbo in Madison Avenue. Tuttavia Morini, da ex bancario, si trova tornato all’origine, ma questa volta in braccio alle banche creditrici e i Mercattilii brothers ricevono delega fiduciaria nel perpetuare una leggenda, quella del San Domenico, spalmata su più rutinaria corsa settimanale.
L’ultima volta che siamo tornati è stata una fitta al cuore.
C’erano ancora alle pareti i quadri di Piero Buscaroli, eclettico uomo d’ ingegno che sa discettare indifferentemente di Mozart e Beethoven come di acquerelli, ma Morini era delegato in un angolo, assopito a custodire i numeretti del guardaroba con l’indegno Mercattilii di sala che, ad una nostra richiesta di visionare qualche bella boccia millesimata, ci ha risposto che, ormai, “i vini vecchi non piacciono più a nessuno” … chissà se è anche per quello che il Tavolo dei Dodici Cavalieri di palato e cantina, adesso, è diventato un deposito di scope…
***
Risaliamo a Nord.est, non prima di esserci fermati a far benzina ma, dalle parti di Casalecchio, oltre la pompa e la licenza di sale e tabacchi, si trovava la Trattoria Biagi, un mondo tutto da scoprire prima che, nel futuro degli autostradanti, comparissero spizzichi e bocconi.
La Trattoria Biagi, in effetti, era un wordl apart.
Sui primi tratti della porrettana si era sviluppata come dependance di un’ area di servizio, appunto, e i cui tavoli erano progressivamente diventati accogliente ostello di dove trovare i tortellini undici-11 sul piatto come tradizione comandava.
I ricordi, ovviamente, sono sfocati, ma rivediamo un grande Gelato alla Crema, con un goccio di Balsamico (pensate, anni dopo abbiamo “insegnato” il trucco di umile trattoria allo stellato Miramonti l’ Altro, dove a crema si aggiungeva banale chocolat).
Grande il Gelato alla Crema e grandi i Biagi, anche e proprio in senso fisico, dall’omùn padrone di casa al giovane figlio obeso e pacioso, che però si poteva capire se era cresciuto tale, con simili tortellini e mortadella come balie di palato.
Poi, un giorno, la pompa ha chiuso e, forse, con le ultime gocce nel serbatoio, Biagi si è trasferito in centro, abbastanza vicino, tra l’altro, all’ allora Pernice et Gallina.
L’ambiente, tuttavia, non era più quello che sapeva di anni ’60 e di miracolo, non tanto economico, ma di stupore al piatto.
Il vecchio Biagi c’era ancora, più decorativo che altro, e il giovane figlio obeso e adulto gestiva il palcoscenico con piglio più cittadino. C’erano ancora i Tortellini in formazione tipo, così pure come il Gelato alla crema, ma qualcosa era oramai cambiato, forse irreversibilmente, e ci dicono che l’ insegna biagia si è ulteriormente trasferita in un peregrinare petroniano che, forse, non troverà più l’approdo felice che aveva tra i fumi di ottani e trinciato forte.
***
Costeggiando la Romea di può arrivare lentamente in Friuli e nel suo vero cuore pulsante, quella Carnia che non ha dato solo il nome a cacio pregiato.
Forse il muro di Berlino non era ancora crollato, ma già le crepe erano evidenti, e quindi il Friuli, patria storica di sgnappa e alpini, era anche regione di frontiera e bastione d’occidente, e quindi con la più alta concentrazione nazionale di casacche in grigioverde.
In questo clima buzzatiano di confine, corroborato da tajut e fogolar, aveva preso piede la Cucina di Gianni Cosetti, con “Il Roma”, a Tumieç, alias Tolmezzo.
L’ Ambiente e la Cucina erano ricercate, ma con buon gusto e senza fronzoli.
Lì abbiamo conosciuto il Fricò (quello vero, non unto e bisunto) e i Cialson, una delle innumerevoli versioni del fare gli gnocchi a nord di Udine e lì abbiamo conosciuto, anche, uno degli amori della nostra vita, quel Pignolo di Girolamo Dorigo che, ancora adesso, è boccia rara e prelibata, ma anche il fratellino minore ci era subito diventato simpatico, quel Tazzelenghe che, come recita in vernacolo, ti “taglia la lingua” per il suo essere rude, un po’ aspro, ma buono assai, come la sua Terra e la Cucina di Gianni Cosetti.
Un uomo segnato dalla vita; pioniere di Cucina d’Autore in una terra dove si è sempre badato al concreto e non al lusso da cittadini, che pure facevano la fila per venirlo a trovare. Lui era riservato, ma cordiale; la sorella, in Sala, non era proprio perfetta ambasciatrice di tanta bontà.
Ma la sosta valeva sempre la pena.
Poi la malattia ha preso entrambi e anche il dolore, perché sembra che al Gianni sia venuta a mancare la figlia e poi, per conseguenza, forse anche la salute.
***
E torniamo sui nostri passi, dai quali siamo partiti novelli dottori.
All’ombra del Bo’ c’era il Belle Parti che un giovane e capelluto Angelo Rasi aveva rilevato dalla gestione del defunto Toulà, consolato patavino.
Poche esperienze, ma una da ricordare: una Cena elettiva con l’ allora Mago del malto torbato, quel Silvano Samaroli che, con i suoi Caol Ila e Ardbeg, aveva fatto sognare palati di giovane beva come di inveterata militanza, con profumi e sapori che sapevano di Highlands e nuove frontiere.
La prima acetaia in proprio l’abbiamo incontrata da quel vecchio istrione di Mario Di Natale, già patron con la tavola del Falconiere del driver Riccardo Patrese, e poi reinventatosi con “L’Antico Brolo” su ristorazione d’alto bordo, all’interno di un Cortile (Brolo) monacense, che ci divertiva con i suoi millesimi (?) balsamici o con dei Tagliolini al profumo di cedro.
E come non ricordare il San Clemente. Locale coraggioso e suggestivo, voluto da un Architetto gastro.ispirato, in interni settecenteschi.
Coraggioso perché, allora, fu il primo ad andare controcorrente proponendo una specifica Carta di sole Frattaglie.
Suggestivo perché, tra salotti e salottini, i tavoli erano disposti tra pareti ricoperte di librerie e qualche tela d’autore, sì che potevate baloccarvi, nell’attesa, leggendo un volume preso dalla parete a fianco, manco foste nello studio di famiglia.
Poi, poi nella strada del ritorno verso casa, nell’operosa periferia della laboriosa città, un’ insegna, una calandra al plurale. E lì, nell’autunno del ’93, l’allora stellata Rita Chimetto in Alajmo, portava a conoscere, Cornelia tra i tavoli, a fine serata, il suo goiello di cucina, tale Massimiliano; l’altro, Raffaele , era già in trincea millesimata da qualche anno.
Avevano da poco tolto le perline in legno alle pareti, e si vedeva che il locale stava imboccando una nuova strada e nuove avventure …
… e poì, da lì, il giro è ricominciato e continua ancora - piacevole e inde,fesso - ancoroggi.
Tank you for your attention.
Sararlo
(*) poiché è stato scritto il tutto di sola memoria, alcuni passaggi o citazioni potrebbero presentare delle imprecisioni, si spera, venali.
Categoria: Sararliche
Questo sito è un Minotauro Virtuale,
nato dall'incrociarsi
di racconti scritti e visivi,
in un luogo di confine tra
un Vittoriale Gastronomico
e il Paese dei Gastrobalocchi

Tag principali
© 2009 - 2025 powered by Sararlo
progetto grafico Helvetika · sviluppo Quamm Web Agency Padova